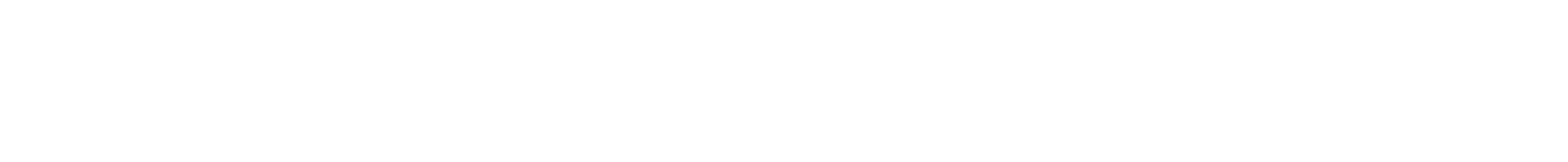<Riuscirò per le mie ossa dure
per i topi che sento dalla mia camera
per questa disumana solitudine …..>
GILGAMESH
E’ il quinto e ultimo libro di Clemente Di Leo. “Gilgàmesh” è l’opera che conclude l’intensa ma brevissima produzione letteraria del poeta di Colledimacine e che chiude anche la sua vita. La raccolta viene pubblicata una manciata di giorni prima della sua morte: viene finita di stampare il 22 giugno 1970 nella tipografia “Arte della stampa” di Bastida a L’Aquila. Egli muore il 5 luglio successivo: ha appena il tempo di “odorare” le pagine fresche d’inchiostro. I volumetti rimarranno ammucchiati negli scatoloni nella sua stanza da letto.
“Gilgàmesh” viene pubblicato in seguito al concorso aquilano “La madia d’oro”, che Di Leo ha vinto. Il premio consiste anche in alcune centinaia di migliaia di lire che il poeta non riesce a intascare personalmente. Perché il cuore – quel cuore da sempre malato – un mattino d’estate lo tradisce. Ci penserà il padre, successivamente, a ritirare quella somma di denaro. E a ricevere gli onori…
Il testo si apre con un poemetto mitologico su Gilgàmesh, eroe di uno dei più grandi poemi epici dell’antico oriente che “insegue per tutta la vita l’immortalità, indomabile e indomito fino a quell’estremo punto in cui deve piegare il capo alle invidiose divinità della morte. Ed è – scrive Giuseppe Rosato su “Il Mattino” di Napoli – un simbolo questo personaggio riscoperto dal Di Leo e fatto proprio, cantato come se veramente avvertisse intanto di stare cantando la propria vita…”. Il testo contiene anche ventisette poesie, tra le più belle dell’autore.
L’introduzione, del 12 giugno ’70, è firmata da Giuseppe Porto che definisce quella di Di Leo “La poesia dell’esplosione” e spiega: “La poesia di Clemente Di Leo scaturisce dalla roccia, dagli stagni, dalla zolla, dalle cantine, dalle carte del tressette, dal sole: è tutto strano nella vita e nell’opera di questo abruzzese cresciuto come un toro, ribelle e spavaldo, di questo avversario della letteratura e del commercio culturale, autodidatta dalle molte e disordinate letture: ma tutto vi è autentico, come un poderoso muggito, un’eruzione o un sisma, o come un’inondazione e un’esplosione stellare, o anche come il grugnito dell’amico maiale e la morte d’un fiore.
Mettiamo da parte l’ingenuo esperimento del Frammento lirico (1963), che si riduce al puro delirio di chi prende contatto per la prima volta con la favola della poesia , e Cimeli (Pescara 1964): in ambedue le brevi raccolte ricorrono ancora certi atteggiamenti, anche esteriori, di fastosa grandigia, che sono la “Definizione della poesia” a firma di Leo Fosco, il commento, il “manifesto foschiano”, delle inaudite sentenze “in limine”, la lunga glossa chiarificatrice del titolo, la formula di “edizione principe”, la “Nota introduttiva”; si aggiunga che ambedue i volumetti sono usciti sotto una falsa veste, poiché hanno per autore un Massimo Rocovic e per editore (in proprio) un Clemente di Leo: Rocovic, Di Leo, Fosco non sono che la medesima persona, Clemente Di Leo, amante ancora immaturo d’una musa giunonica.
Mettiamo anche da parte, del Di Leo, alcune espressioni solecizzanti e informi, presenti nella sua prosa; e l’estroso espediente di farsi passare per il raccoglitore di scritti inediti del defunto poeta contadino Antonino Teseo onde destare l’interesse delle riviste (“Dimensioni”, “Il Ponte”, “Palaestra”, ecc.) e della critica; e gli annunci d’altre opere strabilianti: tutto infatti si può perdonare a chi smercia i sogni sulla bancarella della poesia, specie se poi l’amore dell’arte gli fa dire cose non comuni che la gente non comune non riesce a intendere.
L’opera del Di Leo – viene evidenziato – prende il volo con “Frantumi di una reggia azzurra” (Poesie – quasi un poema, Milano, Muscente, 1966), questa volta con firma autentica; con la raccolta dei suoi venti anni l’autore crede di aver raggiunto il proprio “zenith”; l’esperimento, egli dice, “potrà essere ripetuto ma non superato”. In effetti il balzo è enorme; il contadino autodidatta, il ragazzo selvatico che ama posare sull’aridità d’un costone roccioso, il daziere delle trentamila lire mensili, il “collaboratore saltuario di varie riviste culturali”, il picaresco rapsodo ha raggiunto quanto voleva: chiudere dentro un cerchio magico di cose e di parole, soprattutto di cose, la sua poetica originalissima, che “sta oltre ogni/posizione: e suona e non suona ad un tempo/per non essere voce o silenzio”; egli ripudia la spocchia accademica e scoppia in risata sonora allorché il poeta, tornato in se stesso, dopo il possesso del dio, avverte l’insinuarsi di un’ombra di commozione; e lancia una sfida da paladino sprezzante alla trimurti ermetica, alla quale mille adoratori s’inchinano levando inni per piegarli alla grazia del favore; per il Di Leo essi sono soltanto “tre ruscelletti magri” che hanno avuto, tutti e tre, “la colite”.
In “Frantumi” si rivela dunque un poeta scanzonato e gentile, ormai sicuro di sé, a contatto con la natura delle cose e la vita dura di tutti i giorni, senza ideali astratti, privo di tentazioni formali e di leccature di maniera, libero e vergine come una pianta. Egli dice: “Quest’arpa…/ha vibrato silenziosa e magnifica/sulle cassette rosse delle api in calore/e tra le foglie fetide/degli stagni in decomposizione”; ha saputo la grazia delle acque di Colonia “sotto gli orecchi bianchi/ed il fetore delle mie scarpe contadine”.
Nell’inarrestabile processo poetico del Di Leo rimangono fermi alcuni aspetti: uno è quello dell’”energia” lievitante; l’altro è il concetto della ispirazione che scende dall’alto unito alla convinzione della necessità, per chi accoglie l’afflato del dio, di produrre la sua onda con la pressione che la natura concede alla polla d’acqua perché possa scaturire dal corpo della terra: tutto avviene pertanto secondo una legge di natura, al di là di ogni artificio della tecnica e anche della logica: “Voi non saprete mai Questa Poesia. Questa Poesia sono Io, è legata a me stesso, ed è pertanto in tanti miei sguardi, in tanti miei soliloqui, è in indeterminate mie avventure ed evocazioni di cui voi non avete visto e non vedrete mai l’eternità” (cfr. E. Rossi Lamberti, premessa a “Frantumi”). Il poeta è dunque portatore d’un miracolo e d’un mistero, talora anche inconsapevole; a lui è concesso il privilegio di rivelarli in nudità d’anima; ma la poesia rivelata non è che un’ombra rispetto a quella che interiormente l’agita: il poeta stesso è poesia.
Da tale situazione derivano i motivi che si alternano senza fine lungo i registri del canto: quello selvaggio dell’amore e della sensualità che si sfianca in rinuncia, perché “stanchi di piacere”; quello della fuga senza sosta dalle realtà conosciute (“Dobbiamo sempre fuggire sorvolando/ogni cosa già usata”): di questa evasione sono simbolo gli “sciolti cavalli” che liberano dalla nausea d’un mondo abitudinario e dalla noia dei gesti macchinalmente ripetuti (“Stasera non scrivo./Sono sazio di tutto). La sensualità è resa con la stessa evidenza con cui sono realizzati certi scorci della natura abruzzese, vergine e aspra, e per ciò pura. Ne è da trascurare il motivo dell’esotismo, specie orientale, che ha in sé il fascino dell’ignoto; l’amore dell’esotico non è mai un atteggiamento di maniera, ma l’imperativo di esprimere una stupefazione ch’è comune a noi stessi se ci accorgiamo di respirare l’alito d’una eredità di millenni trasfusa in noi dal mistero delle trasmissioni lontane: come una voce di tamburo che ci arrivi dal deserto. E tutto è espresso alla stessa maniera violenta e inquieta, talora con fare da guappo, con parola saporosa e succulenta e con l’ardire che nasce dall’orgogliosa considerazione di sé e della propria ponderosa presenza nei confini della vita: questo è il tono che prevale in “Una lunga puzza”, dove si ribadisce la definizione della poesia, una poesia forse troppo sovrabbondante, ma che va a coincidere, come avverte Giuliano Manacorda, “con una stupefacente consonanza, con quelli che sono i modi più autentici del poetare oggi”:
“Ridatemi le carte, fifoni, /voglio andare in bestia./Quattromila lire, tutto quello che ho/per me è come niente”. E ancora: “Poesia, ti ho in mano come una mela marcia/ma se ti lancio, brilli come una cometa./Averti addosso è una lunga puzza/ma se dico “Su, entriamo anche noi”/tu ti fai una grande signora/ed io un cavallo odoroso./Suggestione del presentatore!/Noi in una sala pulita/non abbiamo niente da fare”.
La conclusione trova i suoi risvolti nell’inedito “Gilgàmesh” (altro ritorno al mistero dell’epopea d’Oriente, che vede nel quinto re della I Dinastia di Uruk l’eroe dell’antico impero numerico-assiro-babilonese), che si rifà per molti versi a “Una lunga puzza”, ch’è, secondo il nostro parere, l’opera più compiuta e matura del Di Leo, fino ad oggi. Vediamo che cosa vi è detto della natura della poesia, che sostiene sempre il ruolo della protagonista: “… Dai pori del tuo corpo/senti crescere gelsomini/e il loro delizioso profumo/stura il muco delle tue narici./Stai come un Dio su un fiume solenne/che ti trasporta e lava/il giallo delle tue orecchie”. E in Ballata: “Nonostante la fine della letteratura/ – e mo come faremo noi poveri lettori?-/… è sempre inconsistente/la percentuale dei suicidi”; in “La razza del poeta”: “Io parlo dovunque mi conduci./Qui sta la razza del poeta nato”; e infine un verso come i seguenti, di sfida a tutte le consorterie, lanciata con la fionda del pastore: “Venga avanti chi si dice poeta./Qui lo voglio vedere/sui colli o sull’asfalto/nella sua maniera di fare e di dire./… Mi sarei impiccato da un pezzo/se la parola non mi scoppiasse/quando sto camminando,alla gola”; o come questi altri, dal medesimo attacco, riportati dal Manacorda nella sua nervosa prefazione: “– Venga avanti chi si dice poeta/qui lo voglio vedere,/anche tra gli sterchi di muli/tra le ortiche mosce”. E sentite con quale straordinaria sicurezza e con quale – diciamolo pure – impudica, ma franca esplosione, Di Leo si pone a fianco ai poeti maledetti, a Francois Villon, a Rimbaud, a Lorca, eccetera: “Poeti come me si contano/sulle dita di una mano”.
Siamo in cospetto d’un amore folle per la Poesia, esclusivo come l’amore per una donna dalla bellezza eccezionale il cui “hortus conclusus” sia guardato a vista dalla sentinella della gelosia: l’amante l’afferra, la fa sua completamente e poi la getta via con fastidio; pronto però a riprenderla subito dopo per la sensazione d’un nuovo orgasmo e d’un nuovo appagamento; mai disposto a cederla ad altri, perché è la sua Signora. Così il tempio della Poesia ha trovato un suo originale adoratore; diciamo pure, un altro suo sacerdote, il signore della pioggia e del vento, il distruttore e il dissacratore, ma anche il creatore di miti, il lanciatore di richiami disperati, tali da sfondare la membrana dei sordi o dei sornioni e degli snobbatori invidi e meschini (quanti ce ne sono!); e la Poesia ha trovato chi sa maneggiare la sua frusta anche sul suo corpo di luce, quando essa lo fa soffrire, come sui mille tabù disseminati sulle nostre strade: egli vive all’ombra come un pirata e il suo petto “respira incensi”; cavalca un “cavallo saldo/pronto a partire dove vuoi”; egli che, se muove un dito, può realizzare i suoi sogni.
Ma la poesia del Di Leo è anche una lezione di virilità, che egli ha appreso, a sua volta, e direttamente, dalla parola della vita e della realtà della morte: “Educate i bimbi alla morte./E’ irreale l’unica cosa vera/ma lì scoppiano i colori della vita/da lì ogni uomo è un atleta”. Ed è un invito alla operosità intensa: “La vita è una creta che puoi/modellare come vuoi/una mazza fresca su cui puoi intagliare/qualsiasi disegno!”.
L’Aquila ha voluto premiare così, in Clemente Di Leo, davvero una forza della natura, la natura vergine d’un Abruzzo che resiste; un’angoscia che si fa allegria.
Di seguito l’elenco delle poesie contenute nel testo:
GILGAMESH
Edizioni “La Madia” – 1970
Gilgàmesh
Ballata
E’ magnifico essere poeta
Col suo grido giallo
Margherita
Questa arancia di sole
Sul tuo grugno, mio porco
L’angoscia mi fa allegria
Faccia di kaiser
La morte
Ciliegie
Sole
Guappo
Il gelato
Non piove più
Scekspir, ti odio
Ti conosco
Ragazzo portami
Ho solo te
Oh l’avessi
Ti ho ritrovata
Buddha
Massenzio, ore 3,15
Memorie d’inverno
Specchio
Tatiana
Che si dice un vecchio
Isabella


<Lo sangue mio, il sangue mio, gridai,
ha le piaghe, e, per esso vane le stelle…..>
FRAMMENTO LIRICO
E’ l’industrioso libricino d’esordio “Frammento lirico”, realizzato negli anni dell’adolescenza. E’ del 1963. L’opera è interamente frutto del giovanissimo Clemente Di Leo che tira fuori i soldi per la stampa e che, per creare interesse intorno alla raccolta e a se stesso, inventa “un complesso artificio di pseudonimi”… E cioè che Clemente Di Leo è l’editore che ha raccolto i componimenti di un suo amico straniero, Massimo Rocovic, che è morto suicida. <Il quindicenne Rocovic – spiega in una nota – compose questi versi frammentariamente, cioè senza ordine o trama, obbedendo al libero istinto e alla fantasia che lo addussero in un mondo per noi isolato, remotissimo>.
Di Leo scrive anche la prefazione del testo, spacciandosi per il commentatore Leo Fosco, che attacca: <La Poesia è la Grazia del Creatore, l’altezza somma del creato, che soltanto un uomo divino, il Poeta, che la sente e canta, può intuire. Di tutta l’umanità Omero, Eschilo, Virgilio, Dante, Petrarca, Shakespeare, Corbeille, Camoes, Goethe, Alfieri, Foscolo e Leopardi sono Poeti, uomini divini; e se nella storia della letteratura figurano altri nomi con simili attribuiti, questi pur se raggiungono una certa commozione e sincerità restano sempre poeti di mezzo o letterati affatto. La Poesia, nel vero della parola, è eterna: pur quando col Sole si spegnerà la Vita, infinitamente bella e misteriosa governerà sul nulla; la Poesia è unica: difatti nessun Poeta è inferiore all’altro.
Dunque, Poeta si nasce, la Poesia è una e di Dio.
No, vigliacchi, vi prego, non sciupate questo nome divino>.
In copertina il c’è viso incantato dell’autore-ragazzino che si definisce “nuovo vero poeta” d’Italia.