Biografia
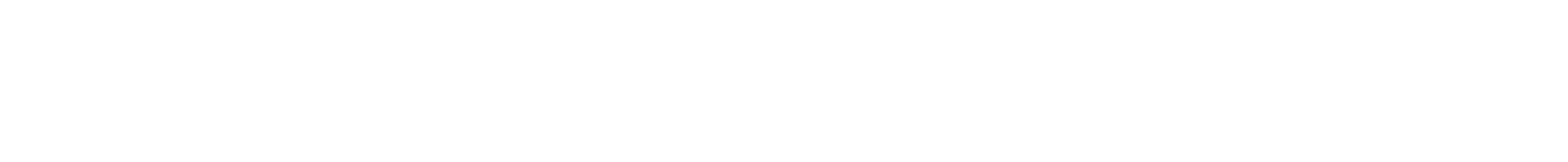
Un poeta... in poesia di Conny Melchiorre

Marianna Delli Pizzi, madre del poeta
Un poeta… in poesia
di Conny Melchiorre
Il cammino per Colledimacine, “la reggia azzurra”, è immerso nel verde…
La Majella come un arcano guardiano accoglie i visitatori.
Le vie cittadine sono larghe, le case per lo più disabitate e, mentre ci affrettiamo per raggiungere la meta del nostro viaggio, un alito di vento rincorre, in un turbine, mucchi di foglie cadute dagli alberi.
Saliamo alcuni gradini. Ecco la casa.
Una targa affissa su una delle facciate cita …<Dirupi d’Abruzzo sono la mia reggia. L’ho colorata d’azzurro con la mia voce frantumata in getti di parole>.
Un po’ di emozione ci sorprende, noi che già sappiamo chi andremo ad incontrare. Suoniamo.
Dalla finestra del primo piano si affaccia un’anziana signora… Lo sguardo celeste sorride.
<In alto c’è la luna d’aprile e corre nell’aria un fremito di giovenche sciolte a galoppo sui colli bianchi. E’ tempo di baci>.
<Mio figlio Dino scriveva di continuo, e quante ne ha combinate intorno alle sue poesie … era sempre pronto a far sorridere, ed era bello, guardate com’era bello. Tutte le ragazze in paese avrebbero voluto averlo per marito>.
Il soggiorno è tappezzato di grandi foto che ritraggono un giovane forte e robusto, circondato dalla natura. Un po’ più di attenzione. Ci avviciniamo, sembra … eh sì, dalla madre ha ereditato gli occhi brillanti.
E’ morto giovane Clemente Di Leo, Dino, come lo chiamavano in famiglia, aveva solo 24 anni; eppure, nonostante l’età ha pubblicato tanti componimenti, gelosamente custoditi dai fortunati che sono riusciti ad acquistare le sue raccolte, oggi quasi introvabili.
Nella mente di chi lo ha conosciuto, un ricordo indelebile dell’entusiasmo nella passione di vivere.
<E’ magnifico essere poeta. Hai in gola un vaso di marmellata e nelle viscere un velo di seta che preso anche da un’aquila o da un missile e tirato per sempre negli spazi non si arrende mai, della sua infinitezza anzi può avvolgere tutto l’universo […]>.
Clemente Di Leo nasce il 30 marzo 1946.
Rimasto nel borgo natio, Colledimacine, a causa di una malformazione cardiaca che non gli permette una vita frenetica, si dedica alla poesia da autodidatta, confrontandosi con la maestosa letteratura europea e intervenendo con presenza vivace e polemica ai fermenti che animano negli anni Sessanta i convegni di poesia nella provincia di Chieti.
<Quando Dino finì le scuole elementari – racconta la mamma Marianna Delli Pizzi – il dottore mi consigliò di non fargli proseguire gli studi, perché continuare a frequentare la scuola lo avrebbe affaticato troppo. Ma lui si comprava i libri e studiava da solo>. Con passione e senza risparmio di energie. Così, in breve, raggiunse un alto livello di preparazione, che gli permise di affinare il suo stile. Di Leo iniziò a scrivere quando aveva otto anni.
<Dino da piccolo aveva problemi a causa delle tonsilli e aveva spesso la febbre – racconta la sorella maggiore Concetta – Per dargli un po’ di sollievo gli scaldavo il latte e glielo portavo a letto. La sua stanza era al piano superiore. Un giorno mi accorsi che il bambino sentendo i miei passi su per le scale si affrettava a nascondere qualcosa tra la rete e il materasso. Scoprii che erano dei foglietti di carta su cui scriveva le sue prime poesie che celava gelosamente. Fu il nostro piccolo segreto>.
Bruciò, come lui stesso racconta, più di 2 mila versi. Si salvarono dalla fiamma quelli che egli reputò essere i migliori… <Ma chi avrebbe mai pubblicato la raccolta di un diciassettenne?>.
<Dino un giorno tornò a casa – racconta la madre – ridendo a crepapelle, felice … e gridava, gridava… “Ci sono cascati, ci sono cascati”. “Ma chi ci è cascato?” gli chiesi …>
Il poeta, che di propria tasca aveva pagato le spese di stampa della sua prima vera opera letteraria, dal titolo “Cimeli”, per renderla appetibile agli acquirenti, s’era inventato una storia particolare… E cioè che Clemente Di Leo era l’editore che aveva raccolto gli scritti di un suo giovanissimo amico straniero, Massimo Rocòvic, che si era ucciso. Dino si scrisse anche la prefazione, spacciandosi per Leo Fosco e avvertendo il pubblico: <Cose non comuni non si possono capire da comuni individui>.
Così è riportato nella nota introduttiva: <Nell’ora più critica della letteratura italiana, adesso che la sfrontata pubblicità e premi spesso scandalosi accecano le masse, ecco sorgere la luce di Massimo Rocòvic, nato appena nel 1946 – da notare la coincidenza con la sua data di nascita – che tra il superficialismo dannunziano e l’inaridito e quasi estinto ermetismo resterà certamente una delle voci poetiche più autentiche e singolari del nostro Novecento >.
Nel frattempo cercò di collegarsi col gruppo pescarese della “Quinta genenerazione”, capeggiato da Renato Minore, ma se ne distaccò subito, <convinto di non poter esaurire la propria vena creativa nell’artificio della sperimentazione linguistica, sull’esempio del “gruppo ‘63”, sentendosi come divorato dall’urgenza incontenibile tipica di un enfant terrible, che vuol forgiarsi con la poesia uno strumento di confessione e di lotta capace di spaziare dal privato al sociale>.
Il poeta in un’occasione rivelò: <Mi sono ribellato all’esistenza divenendo forma astratta e puramente gratuita. Ma così non valgo un’albicocca. Non sono poeta letterato ma poeta dell’essenza. Non appartengo alla poesia delle lettere ma a quella vissuta, sentita nella verità del mio spirito>.
Dino Di Leo viaggiava in autobus e andava soprattutto a Pescara, sia per consultare le biblioteche e prendere in prestito pacchi di volumi da leggere, sia per vendere i suoi libri. Camminava sulle spiagge adriatiche, fermava i bagnanti e proponeva loro l’acquisto di “Cimeli”, di “Frantumi di una reggia azzurra”, di “Una lunga puzza”… e diceva: <Costa 5 mila lire, ma se vi fa piacere potete dare qualcosa in più per favorire la pubblicazione della prossima opera>.
<Le lunghe gambe vestite di nero tra i palazzi ti guardi, Cinno – Di Leo si raffigura nel protagonista della poesia – Lastre di alluminio le strade ti carpiscono gli umori di menta; ma i pastori sulla breccia dei colli, urne di Annibale, sono misere scaglie e sbuchi dalla terra dei serpi salutando il letto di cartocci l’ultimo lupo squarciato nel ventre. Non ti preme perdere l’assenzio dei boschi, pure l’alluminio ti canta, fremi ai suoni dei clacson come ai primi cuculi, incredibile Cinno>.
I bibliotecari della De Meis di Chieti lo prendevano in giro.
Quando vedevano arrivare quel ragazzino che abitualmente affrontava tutte quelle ore di viaggio pur di prendere in prestito le opere di Leopardi, di D’Annunzio, di Pascoli gli dicevano: <Queste letture sono tutte troppo difficili per te, ma che ci puoi capire!?>.
Dino rispose: <Vedremo>.
Un giorno gli stessi bibliotecari incontrarono suo padre e gli raccontarono di come il figlio, tornato a restituire i libri, li aveva lasciati a bocca aperta mentre parafrasava i contenuti. <Noi lo punzecchiavamo non perché pensavamo fosse poco intelligente – si giustificarono – ma perché è davvero tanto piccolo per cimentarsi con testi così impegnativi>.
La svolta per la sua carriera artistica avvenne nel giugno del 1970 quando vinse con “Gilgàmesh”, un poemetto di taglio narrativo e leggendario, il premio aquilano la “Madia d’oro”. Per la prima volta la sua opera ebbe un editore ed una vera introduzione corredata da Giuseppe Porto: <La poesia di Clemente Di Leo scaturisce dalla roccia, dagli stagni, dalla zolla, dalle cantine, dalle carte del tressette, dal sole. E’ tutto strano nella vita e nell’opera di questo abruzzese cresciuto come un toro, ribelle e spavaldo, di questo avversario della letteratura e del commercio culturale, autodidatta dalle molte e disordinate letture: ma tutto vi è autentico, come un poderoso muggito, un’eruzione o un sisma, o come un’inondazione e un’esplosione stellare, o anche come il grugnito dell’amico maiale e la morte di un fiore>. <Oltre quello stendere versi – afferma Giuliano Manacorda – non ci sono cattedre, collaborazioni, consulenze, frequentazioni, c’è lo staccare bollette del dazio ( che è il suo lavoro), e cercare di non farsi imbrogliare troppo da qualche mercante>.
E’ il 4 luglio del 1970, Dino di ritorno dall’Aquila, ove si era recato per ricevere il suo premio, volle festeggiare questo evento felice con i suoi amici.
A causa delle sue condizioni di salute gli era proibito bere, mangiare eccessivamente, sregolatamente e affaticarsi.
Quella notte bevve molto, mangiò a crepapelle, e stette fuori quasi fino all’alba, era radioso ed appagato della sua conquistata gloria. E poi si mise a scrivere alla fioca luce. <Non è il caso che riposi un po’?> – gli chiese la madre. <Non ancora…> – rispose alzando appena lo sguardo.
<La mattina – ricorda zia Mariannina, un velo di pianto appanna lo sguardo – mentre sbrigavo le faccende sentii un rumore tanto strano. Mi affacciai alla finestra che dava sulla strada, per vedere se proveniva da lì, ma non c’era nulla. Ripresi, ma il rumore diventava sempre più forte. Mi passò per la testa di guardare in camera di Dino. Era lui. Era lui che non riusciva a respirare ed emetteva quel rantolo strano. Corsi fuori e urlai chiedendo aiuto, accorsero subito però non ci fu nulla da fare, il mio Dino era morto>.
<La notte vien meno, e sorgendo dorata la luce si dileguano le ombre: le vette brillano mormorando alla brezza, mentre nel vuoto tramonta la luna. Leggiadra sui floridi colli corre la vita, e nera nell’atrio buio della vecchiezza erra e sparisce la morte>.
Tanta gente partecipò al funerale, da tutto l’Abruzzo, tra loro quei lettori che Dino aveva conquistato con il suo impeto e con la sua passione.
Gli amici di quella sera, ricordando, ci confidano che forse Clemente Di Leo, quella notte di eccessi si era voluto lasciar morire, quasi per spegnersi nel momento più alto della sua vita, di gioia, soddisfazioni e riconoscimenti.
Il premio materiale, quello, non fece in tempo a ritirarlo, dovette farlo il padre…
<Tempo dopo – ricorda lo scrittore Giuseppe Rosato – mi recai assieme ad Antonino Di Giorgio a Colledimacine, nella sua casa natale. Ci trovammo davanti una quantità impressionante di libri. Clemente leggeva tanto, nonostante i dottori gli avessero suggerito di non affaticarsi, e testi di caratura diversa. Non si era mai curato molto dei suoi problemi di salute. Non s’era preoccupato di salvaguardarsi. Poi – continua – ci recammo al cimitero. Cercammo la tomba, ma non la trovammo. Chiedemmo al necroforo che ci indicò un loculo, ancora in cemento grezzo. C’era scritto soltanto “Dino”. “Dino? Perché Dino?”, domandammo. “Sì, per noi del paese era solo Dino… – rispose il becchino -… Era un poeta in poesia”>.
<Aveva un carattere molto forte – rammenta ancora Rosato – Era molto libero. Era convinto di essere un grande poeta e diventava furente quando non trovava riscontro. E anche quando gli prospettavano la durezza della sua poesia, che era contro ogni accademismo, contro la lirica sdolcinata o paesaggistica, contro gli ermetismi e lo sperimentalismo. Aveva una maniera disincantata di guardare la fatica, il sudore, l’esistenza>.
<Ed era cosciente – evidenzia Pina Allegrini, sua amica, poetessa – che la propria vita non sarebbe durata. Non ne parlava, ma lo sapeva. Nell’animo lo sentiva>.
Bibliografia
D’Alonzo Rolando, Gli ultimi poeti della strada, Chieti, 1973.
Di Leo Clemente, Cimeli, Edizione principe, Pescara, 1964.
Di Leo Clemente, Frantumi di una reggia azzurra, Fratelli Muscente editori, Milano, 1966.
Di Leo Clemente Gilgamesh, Edizioni La Madia, L’Aquila, 1970.
Di Leo Clemente, Una lunga Puzza, Edizione Clemente Di Leo, Colledimacine, 1968.
Mà, diventerò importante di Alessandra Campitelli
“Ma’, diventerò importante”
di Alessandra Campitelli
E’ una storia che ha il colore dell’Abruzzo del dopoguerra, fatta di sogni “rossi” dello Psiup e del suono lirico della terra, della semplicità e della passione.
Quella di Clemente Di Leo è un’avventura che suona forte dentro il cuore della sua gente. Ha lo stupore di un bambino già grande che si racconta in versi. Ha scelto di esprimersi e raccontarsi nella voce della semplicità e dell’immediatezza tra i dirupi d’Abruzzo diventati una reggia di parole. All’ombra dei grandi e passo a passo ai contemporanei. Dei quali poteva permettersi di sviscerarli e descriverli in un racconto irridente e sfrontato. Solo come chi ha letto oltre lo scritto e ha visto le immagini dei versi danzare riesce a fare.
Clemente di Leo è partito da niente, all’ombra della “puteche” di mamma Marianna e papà Italo. Dove si vendeva tutto quello che a un paese alle pendici della Majella può servire. Le caramelle che sapevano di pino e quelle al miele da pescare nei barattolini di vetro, le liquirizie da succhiare che quando venivano mangiate dai piccoli con golosa deferenza davano loro il gusto di un lussuoso privilegio e il tepore denso di zucchero di una giornata di festa. E poi, la pasta “della Fara” venduta sfusa e avviluppata a cartocci di cartapane scura e dura come cartone. Arrivava a Colledimacine confezionata in pacchi da 50 chili, portata in groppa da un asinello. Agli stessi involucri cartonati, duri come il desiderio di riscatto e di cambiamento di un piccolo paese arroccato nella semplicità e nel cambiamento a cavallo tra il niente e il tutto degli anni Cinquanta e Sessanta, Clemente affidava i suoi pensieri, le riflessioni sui giorni e sui momenti, i sogni mordenti di un bambino che aveva la poesia intrisa sulle dita e un destino sedicente davanti al quale trovarsi, un giorno, a 24 anni. Ma che spavaldo ha guardato fluire. Parlava di poesia e respirava poesia della terra, dei colori, dei ciliegi e delle stelle in una epoca brulla di pensieri dove il futuro aveva i tratti dell’emigrazione. Quando anche il linguaggio sembrava ricordare la provincialità di una vita nella cadenza di un dialetto strascicato, Di Leo “parlava in dialetto ma scriveva in italiano”, ulteriore ossimoro di poeta “scapigliato” che ambiva al mondo muovendosi dalle piccole cose.
Oggi a ricordare quei tempi nascosti tra le righe di “Dino” c’è la sorella Concetta. I capelli di un biondo antico gli eventi di un tempo che sussultano sotto il dolore del ricordo. Sugli occhi blu scorrono vive come le lacrime mai seccate per quella morte prematura, le immagini di ieri. Di quella quotidianità vissuta con la famiglia ricca di “risate schioscianti di Dino che all’improvviso si aprivano nell’aria”, di quel fratello “sempre con la penna in mano, sempre un libro in tasca” che ha studiato da solo e si è trovato un giorno tra i grandi. “Ogni immagine che ho di lui – racconta Concetta Di Leo – la ricordo sempre con un sorriso. Mentre tornava a casa correndo quando aveva l’ispirazione di un verso. I bigliettini che ha imparato a scrivere da piccolissimo, la convalescenza dalla tonsillite e dalle “febbri reumatiche” che gli indebolirono il cuore durante la quale faceva pagine intere di parole crociate. Ricordo il suo interessarsi ad ogni faccenda. Era attento e curioso, a volte riprendeva anche nostro padre.”
E’ la storia di tanti, quella dei Di Leo. Imbastita nei giorni dai sacrifici e dall’umiltà di un’epoca. Contadino il padre Italo, poi emigrante prima in Germania, poi negli Stati Uniti. La mamma Marianna aveva un negozietto nel cuore del paese, in via Roma, dove era aiutata dai figli Concetta, Clemente e Franco. Per quel figlio indebolito dalla malattia c’era lo sguardo attento di tutta la famiglia. “Un giorno mà diventerò importante – diceva – verranno qui a chiederti di me, se qui c’ho vissuto io”. Forse proprio per quel corpo sferzato dalle febbri Di Leo ha scelto la strada dei libri, la strada dei versi. “Non poteva andare fuori a giocare e correre come gli altri bambini. Gli amici di Clemente – rivive la sorella – erano per lo più maestri della scuola locale, con i quali si incontrava per discutere di poesia. Con gli altri coetanei non si frequentava molto, preferiva restare in casa a leggere, a studiare ‘tanto – diceva – loro non fanno quello che faccio io, non sono come me’. Lui era diligente e attento. Anche se ha frequentato solo le elementari a causa della sua malattia non ha mai smesso di studiare. I libri da leggere li prendeva in biblioteca, a Chieti. Si recava lì regolarmente in autostop. Raramente in autobus. Andava con la valigia per riportare più libri che poteva. E li divorava attento in pochi giorni, commentandoli e confrontandoli”. Dei testi dei poeti “laureati” si discostava perché lontani dalle cose di ogni giorno (Venga avanti chi si dice poeta/qui lo voglio vedere/anche tra gli sterchi di muli tra ortiche mosce/). Pavese, Calvino, Ungaretti, Quasimodo, Montale, D’Annunzio. Combatteva i grandi come le disparità e le ingiustizie. Acre e risentito, ma aulico e sprezzante nella sua infinitezza di poeta “che può avvolgere tutto l’universo”.
Libri, quaderni e penne acquistati con i proventi delle partite a tressette al bar “Lucio”. Lì dove c’era la televisione e il paese si raccoglieva a guardare Canzonissima e il Festival di Sanremo e che lui, con la sua radiolina rimediata da un commesso del negozio attaccata all’orecchio per “sentire” il mondo, disprezzava. “Giocava a carte per ottenere il denaro necessario per comperarsi libri e materiale per scrivere. Come quella volta che intendeva vincere per comperarsi il dizionario di italiano. Diceva che non gli servivano ‘cenci’ da mettersi addosso. Ma che gli servivano i libri”
Fu persino daziere per conto del Comune. Per diecimilalire al mese. “Doveva riscuotere i dazi delle merci che transitavano nel territorio comunale, ma diceva che riusciva a fatica a chiedere alla gente il corrispettivo in denaro. Perché gli dispiaceva. Non sopportava che ci fossero persone che riuscissero tranquillamente ad approfittarsi dei più deboli, non comprendeva perché ci fosse disparità nei lavori e nei compensi. Amava la povera gente ”.
“Con quelle diecimilalire Clemente inviava plichi di poesie alla case editrici, alla riviste di poesia, ai concorsi. Cercava di farsi conoscere. Ogni volta che ne tornava indietro qualcuno si arrabbiava e restava silenzioso per un po’, come congelato davanti a quel plico. Ma poi subito ricominciava a scrivere”. Quelle delusioni alimentarono persino un falò in cortile. “Era così arrabbiato che una mattina bruciò migliaia di versi. Li giudicava scadenti”. Qualcuno di quei cartocci di poesie legati da spaghi, arrivò fino a Pasolini. Il quale, si dice, riconobbe in quel poeta giovane e scaltro, una promessa. Ma la storia ha spezzato sul lido di Ostia per mano di un ragazzo di vita quella che poteva forse essere la consacrazione di Di Leo. “Era in contatto con i maggiori intellettuali dell’epoca, sapeva farsi conoscere. Spesso in famiglia non sapevamo nulla dei suoi contatti, delle persone che incontrava nei suoi viaggi, della sua corrispondenza. Una volta sposata – racconta Concetta Di Leo – sono andata a vivere a Chieti. Mi ha chiesto di comperargli un pacco da 500 buste strong alla Upim perché gli servivano per inviare le sue poesie ai concorsi. Negli ultimi tempi batteva i testi a macchina. Sapevo che gli avrebbe fatto piacere. Lui ne fu entusiasta e mi ringraziò come solo lui sapeva fare: mi scrisse una poesia”.
Si sentiva la Olivetti scandire il tempo a tutte le ore della giornata. Il ticchettio sui tasti risuonava per tutta la casa. Come quell’ultima notte. Quando nell’aria c’era ancora il sapore della consacrazione della sua poesia. “ Gli era stato comunicato che aveva vinto un concorso a L’Aquila. Si era precipitato lì per saperne di più. Aveva festeggiato la vittoria. Ma non andò mai a ritirare il suo premio. La sera come sempre scrisse fino a tardi. Mia mamma al risveglio sentì come un rantolo, un respiro pesante provenire dalla sua stanza. Quando entrò lo trovò quasi senza respiro”.
Clemente Di Leo si spense alle 7.30 del mattino del 5 luglio 1970.
La sua parabola di versi, parole, pensieri è una vertigine di emozioni e immagini senza fine che percuote e si staglia ancora oggi negli occhi e tra le labbra di chi legge.
Autentico, disincantato, acre.
La bella gioventù di Serena Giannico
La bella gioventù
di Serena Giannico
“Quel giorno Dino in difesa le imbroccò tutte… E quando bloccò l’ennesima pallina diretta in buca, cominciò a sbeffeggiarci. Allora qualcuno urlò stizzito contro di lui…”. Era l’estate del ‘58 e, a Colledimacine, all’ombra verde della Majella, in quattro giocavano a calciobalilla. “Eravamo al “Bar Lucio”, nel centro del paese – racconta Nicola Di Stefano, classe ’39, originario di Colledimacine e che ora vive a Sant’Eusanio del Sangro – indaffarati col biliardino. Marino Delli Pizzi, poi emigrato in Brasile, Orlando D’Ippolito il sarto, io e Clemente Di Leo che per noi era Dino…”. La partita sfociò in disappunto contro Di Leo e la sua strafottenza… “A quel punto il padre Italo, che s’era affacciato, mi chiamò in disparte… ‘Non lo sgridate – mi disse – Dino non sta bene…’. Già aveva problemi cardiaci. E fu proprio il cuore a tradirlo non molto tempo dopo”. Quell’estate Dino aveva dodici anni. Negli studi era un autodidatta dato che la salute malmessa l’aveva obbligato ad abbandonare la scuola dopo la prima media a Torricella Peligna. E già scriveva versi. “Eravamo ragazzi – ricorda Di Stefano, amico inseparabile del poeta e autore del testo “Stagioni perdute” in cui narra la Colledimacine di ieri – e mi parlava dei suoi componimenti… Non lo prendevo sul serio… All’inizio nessuno lo prese sul serio… Poi, nei suoi libri, ho ritrovato la nostra infanzia. Le scorribande nei campi. La voglia di afferrare la vita, pure con le sue asprezze, e tenerla stretta…”.
Tra i “(…) grilli… nascosti sotto il quadrifoglio fortunoso/… e il miscuglio di antichi odori di api/ e colori di fiori violacei e vermigli (…)”, il passatempo dei ragazzi erano le carte napoletane. “Andavamo alla pineta – spiega Di Stefano – e lì ci mettevamo al sole, anche in gennaio. Eravamo in sette-otto… Puntavamo 10 lire ciascuno e giù la sfida… Dino era abbastanza fortunato, ma imbrogliava anche. E lo rivela nella sua “A bestia”… “Sono più belli i soldi sull’erba./ Seduto sulle caviglie/ con le gambe intrecciate/ faccio carte, conto il piatto, è giusto/ e l’indice e il pollice/ più non mi resistono/ per la voglia di barare”. “Quando riusciva a raggranellare un po’ di denaro con le vincite, andava subito a comprar libri”. Quando faceva freddo le sfide, soprattutto a tressette e a stop, si spostavano nell’abitazione di un insegnante di località Colle Zingaro, a Torricella Peligna.
Di sera spesso c’era la biblioteca del Patronato scolastico. “Era aperta e ci passavamo ore, anche a discutere. Dino leggeva di tutto, ma adorava i testi umanistici. E non smetteva mai di prendere appunti”.
Il posto dove Clemente Di Leo era nato racchiudeva circa 600 anime. Una magra realtà distesa ai piedi di costoni rocciosi e falcidiata dall’emigrazione. Il sostentamento era nella pastorizia. In tanti, poi, puntarono sull’allevamento delle mucche e sulla produzione del latte. Così anche la famiglia Di Leo, che gestiva tra l’altro una piccolissima rivendita di pasta che arrivava, in groppa ad un asino, da Fara San Martino. “Dino – evidenzia Di Stefano – non aiutava molto in casa… I genitori gli vietavano di affaticarsi e, così, lo proteggevano. Gli era consentito solo di portare crusca, ghiande e avanzi di cibo al maiale che, quando poteva, viziava con le caramelle e i confettini colorati raccolti ai matrimoni”. “Sul tuo grugno, mio porco/ s’infrange la lontananza delle stelle/ l’infinità della linea retta./ Seduto nella mangiatoia/ soffice d’erba medica/ ti metto i piedi dondolanti sul dorso/ godendomi la canzone/ che tu soffi nel truogolo./ Succhia e canta!/ Io intanto allungo il braccio/ rubo le mele dalla tazza dei conigli/ me le mangio e ti butto i torsi…”.
Di Stefano frequentava l’università di Urbino. “Un mattino di luglio del ‘65 – fa presente – Dino mi fece salire nella sua stanza da letto. Era spoglia, con solo una branda. Lì a terra c’erano scatoloni zeppi di volumetti, di “Cimeli”. Gli proposi: ‘Io debbo andare a lezione, perché non vieni con me e cerchiamo di venderne un po’’? Lui ne prese un pacchetto e partimmo di buon’ora, con la corriera della ditta Teti. Giungemmo a Pescara alle 8.30. Troppo presto. La coincidenza col treno c’era alle 10.45. Allora andammo in spiaggia a vendere i libricini. Lui – viene aggiunto – era singolare sulla sabbia, con quel borsone nero e il cappello di feltro”.
Di Stefano si mise ad insegnare. Poi entrò a lavorare alle Poste e telecomunicazioni. Dal ’64 al ’68, divenne vice sindaco a Colledimacine, sotto il segno della Democrazia Cristiana. “Anzi, – puntualizza – dato che il primo cittadino, Gianni Pignetti, prima fu chiamato alle armi e in seguito fu assunto a Pescara ai Telefoni di Stato, mi occupai in prima persona dell’amministrazione del Comune”. E fu lui il 30 dicembre ’66 a proporre al Consiglio e alla Giunta municipale l’assunzione di Clemente Di Leo come “incaricato alla riscossione delle Imposte di consumo tenuta in economia, e ciò dalla data del primo febbraio 1967”. La delibera fu adottata nel giugno ’67 ed ebbe effetto retroattivo. Così Di Leo – “che aveva bisogno di contanti per provvedere a se stesso e per pagare la pubblicazione dei suoi libri” – divenne daziere a 10 mila lire al mese (anche se lui faceva sapere che percepiva 30 mila lire mensili). Ad insegnargli il mestiere fu il collega della vicina Torricella Peligna. Egli riscuoteva le tasse nei mercati e nelle fiere e quando c’erano nuove costruzioni. “Il compenso non era un granché, in effetti, ma il Comune aveva oltre 20 milioni di debiti. Gli promettemmo che l’aumento, fino a 60 mila lire, sarebbe arrivato più in là”. In realtà lo stipendio non lievitò mai.
In precedenza Di Leo aveva anche tentato di darsi al cucito… “Ma forbici, punti, aghi, fili e pieghe dei pantaloni non erano per lui”. Solo una volta aveva aiutato la sorella, Concetta, ad imbastire il colletto di un cappotto.
Furono quelli anche gli anni in cui si impose al primo concorso letterario. “Mi chiamò – rammenta l’amico – e mi annunciò che aveva vinto un premio a Ferrara. Gli avevano dato un quadro che lui aveva ritirato e appeso in casa, nella saletta. Era raggiante… Finalmente quella poesia per cui lui esisteva, trionfava…”. “(…) Mi sarei impiccato da un pezzo/ se la parola non mi scoppiasse/ quando sto camminando, alla gola”.
Giunsero pure i primi palpiti di cuore. “Nel ’67 a Colledimacine – riprende Di Stefano – vennero in vacanza alcune ragazze di Senigallia. Eravamo seduti sul muretto, una sera, quando queste passarono… Lui si alzò, mi salutò e le raggiunse. In seguito mi raccontò che era stato con una di loro…”. Si erano amati in un podere pieno di fave. “Ah, le fave… che nostalgia di quei tempi…”. “… Compagni che stasera ci attorcigliamo/ per una scorpacciata di fave,/ scusatemi se di botto mi faccio strano,/ barcollo sparlo, se straccio fiori di lupinella/ e li spargo sulla breccia come un santo… Mi accenderò/ la fronte di lucciole, schiacciandole/ come queste fave, delizia delle nostre sere, le fave/ che simili a noi erano gigli dalle unghie nere…”. E il 24 giugno, dopo la fiera di San Giovanni a Torricella? “Che abbuffata di ciliegie…”. “Vado da un ramo all’altro come una gazzella/ e un pugno di ciliegie alla volta/ mi metto in bocca. Scusatemi formiche se vi schiaccio coi piedi…”. “Era ghiotto di frutta, Dino… Certe scorpacciate, insieme…”. Giorni di gioventù… “Sarebbero terminati presto…”.
Era la primavera del ’70. “Dino aveva deciso di darsi alla politica, anche per avere una maggiore visibilità”. C’era la campagna elettorale per le elezioni provinciali e Di Leo si era candidato a sinistra, nelle file del Psiup (Partito socialista italiano di unità proletaria). “Gli suggerii di lasciar perdere – afferma Di Stefano -, perché era logorante. E non se lo poteva permettere… I comizi, i continui spostamenti… Lui non stava bene… Non mi ascoltò e tirò dritto per la sua via…”. Nei mesi dopo Di Leo vide la sua poesia farsi largo. Si aggiudicò il concorso “La madia d’oro” di L’Aquila. Un riconoscimento ambito che gli procurò anche un gruzzolo di denaro. Ma non fece in tempo a ritirare il premio. “Il 5 luglio ricevetti una telefonata di buon’ora. ‘Dino… l’hanno trovato morto’.… Quel testone, se n’era andato…”.
“Era intuitivo, impulsivo, passionale. Sapeva di valere ed era cosciente del fatto che avrebbero scoperto, compreso e apprezzato la sua poesia dopo la sua fine. Si dava da fare. Voleva fuggire da quei luoghi che non gli offrivano opportunità”. La memoria riaffiora. Corre a quelle foto scattate insieme sul colle, con Di Leo con il pugno alzato… “Perché era comunista”. Va alle passeggiate sui monti Pizzi, la “contea dei ginepri”. Alle risa sui prati di margherite. E alle raccomandazioni di Mariannina, la mamma di Dino, quando li vedeva uscire… “Nicola, stai attento… Non può sudare. Non si può stancare…”.
Clemente Di Leo di Antonino Di Giorgio

Clemente Di Leo
di Antonino Di Giorgio
Ricordo di Clemente
Non l’aveva mai detto a nessuno, noi non sapevamo che fosse malato. C’era sempre apparso pieno di salute, forte nei polsi e alla cervice, ispido e un po’ goffo, con quella grossa ossatura ancora non ben assestata, come succede spesso ai montanari giovani. “Era la superbia della giovinezza!”, ci dice ora suo padre. In effetti, all’età di dodici anni, per le complicazioni seguite ad un’operazione di tonsille, Clemente Di Leo aveva contratto un grave vizio cardiaco. Aveva appena fatto la prima media e si fermò lì, non poté più proseguire gli studi né avviarsi a qualche mestiere. Da qualche anno faceva il daziere, un incarico forse puramente onorifico dato che a Colledimacine, un paese che l’emigrazione ha ridotto a settecento abitanti, c’è ben poco dazio da riscuotere. Aveva una Olivetti portatile e con quella scriveva lettere per conto dei paesani, le lettere tragiche che si scrivono da questi paesi in perenne attesa di sussidi, dove la sventura, individuale o collettiva, si risana, se si risana, con una lentezza che esaurisce la vita: Al Consolato Italiano di Perth – West Australia, per chiedere notizie del marito che da dieci anni non si fa più vivo; Al Ministero della Difesa – Ufficio Pensioni di Guerra per sollecitare la pratica del figlio scomparso in Ucraina nel gennaio 1943; All’Intendenza di Finanza – Ufficio Danni di Guerra, allegando l’atto di notorietà da cui risulta che la casa fu minata nel dicembre 1943. “Dino” (così lo chiamavano in famiglia e in paese) “non si rifiutava mai ma non prendeva una lira da nessuno”, ci dice ora sua madre.
A far vivere Dino, il figlio tarato e geniale che da un momento all’altro può venir meno, pensava il padre. E naturalmente, poiché in questi nostri paesi l’affetto è troppo facile, non vale, se non è provato dalla distanza e dalla lacerazione: Dino stava a Colledimacine e il padre a lavorare in Westphalia. Lui gli ha fatto comprare questa catasta di libri, ben scelti nelle edizioni economiche, e la Olivetti che principalmente gli serviva per scrivere le sue poesie, lui ha pagato le tipografie che hanno stampato le prime raccolte di versi e le lunghe filze di francobolli per scrivere agli editori, ai letterati, ai critici, alle segretarie dei premi letterari nella ricerca assidua, smaniosa, spavalda, spregiudicata, di un successo che lui sapeva spettargli e che appena adesso aveva cominciato ad arridergli. Un suo verso dice: “Poeti come me si contano sulle dita di una mano” e Peppino giustamente osserva con noi: “Chiunque altro l’avesse detto sarebbe stato ridicolo; detto da lui invece no, perché lui ci credeva veramente”. “Vedrai – diceva Dino alla madre – tra poco i professori d’università verranno a domandarti: quando ha cominciato a scrivere? In quale stanza scriveva? Di giorno o di notte?”. Lui era padrone di queste certezze, senza le quali la professione di poeta diventa una routine.
Io, Peppino e Camillo non siamo professori d’università, ma sono queste all’incirca le domande che facciamo alla madre nella sua casa, l’8 luglio, tre giorni dopo che Dino è morto. Suo padre queste cose non le sa, perché sui sta in Westphalia a fare il suo dovere in fabbrica, e insieme a noi ascolta con curiosità quel che la mamma racconta. Non si può dire quando Dino ha cominciato a scrivere, ha scritto sempre, tra quando ha finito di scrivere per i compiti di scuola e quando ha cominciato a scrivere per conto suo, e cioè del tutto inutilmente, non c’è quasi stata soluzione. La malattia lo ha aiutato, si sa che la malattia, quando colpisce un adolescente già predisposto, segna la svolta, è lei che assolve l’ozio, che distacca e disincarna, che spinga il poeta a venire al mondo.
Scriveva in questa stanza che ora ci ospita tutti, i tre forestieri in visita di condoglianza insieme al padre, alla madre, al fratello, alla sorella, al cognato, ad una coppia di zii, e a un nipotino in culla che in questa casa dominata dalla morte fa ancora sorridere e pensare al dopo. E’ una stanzetta da pranzo luminosa, in una casetta decente, dove, subito dietro il portoncino, è stato sistemato un minuscolo banco per lo spaccio di quelle scatole colorate che contengono crackers, detersivi superattivi, cibi sotto vuoto, e che qui giungono come messaggi affievoliti dal mondo delle fabbriche e delle attività terziarie. Fuori, il paese, rifatto dopo la guerra, è pulito e per niente pittoresco, anzi informe, con strade troppo lunghe e troppo vuote; tre graziose ragazze in calzoni passeggiano accidiosamente; un puledro sbandato rincorre la madre che si allontana sulla curva, tirata a cavezza verso i campi infalciati dove Dino camminava spingendosi avanti una mandria di grilli.
Scriveva più di notte che di giorno, dice la madre. Sempre inquietamente. Lei sentiva una breve raffica sulla Olivetti, poi un lungo silenzio, poi una battuta più stenta, poi Dino usciva, si affacciava a questo muraglione che corre sul fresco di un vallone, rientrava di corsa, scriveva altre due o tre parole, e poi di nuovo usciva e si sporgeva sul muraglione per cercare l’altra parola che ancora mancava. Le diceva: “Quando mi vedi coi compagni o faccio una bolletta, io sono uguale agli altri. Uguale uguale. Ma quando scrivo io sono un’altra persona”. Dino non faceva l’eremita, a Colledimacine ci stava dentro; in agosto, quando gli emigranti tornano dalle città di Europa, giocava a carte con loro, accoccolati intorno alle panchine della pineta; e anche a Natale, nel fumo dell’unico bar, giocava accanitamente a Bestia. “Vinceva sempre!”, dice la madre e questo le sembra un altro aspetto prodigioso di suo figlio.
Le diceva pure: “Mamma, io un giorno faccio la valigia e me ne vado”. “Ma dove vai, figlio mio, che qui non ti manca niente!”. “Me ne vado e non mi vedrai mai più”.
Di tanto in tanto, con l’autobus che d’inverno parte a notte fonda, col passaggio offerto da qualche paesano o con l’autostop, Clemente scendeva a Pescara e a Lanciano. Come il lupo è roso dal pensiero della caccia anche quando non ha fame, così Clemente, curvo e strinato, si aggirava in queste città, roso dal pensiero della poesia. Vi annusava la materia di nuova poesia per rifornire il laboratorio di Colledimacine, e vi portava la poesia già fatta per spanderla, venderla, regalarla, smerciarla a quanti più si poteva. Spinse i suoi raids fino a Roma, ma non sappiamo come lì fu visto, perché a Lanciano il retroterra da cui veniva può ancora essere compreso nella sua realtà senza folklore, ma a Roma è più difficile, poteva finir vittima dei patiti della civiltà contadina. Naturalmente cercava anche donne, molla segreta di ogni viaggio, fuga ed evasione, essenza di ogni poesia, e qualcuna trovò. C’era una, dice la madre con costernazione, che gli faceva delle telefonate che costavano almeno diecimila lire. E lui trionfava di queste lunghissime, forse supplici telefonate e con quella sciocca iattanza cui i giovani maschi non possono sottrarsi le diceva: “Più le maltratti più ti si attaccano!”.
Oppure, di notte leggeva. Fu sua fortuna che né la madre dalla stanza accanto, né il padre dalla Westphalia gli abbiano mai rimproverato il consumo della luce. Avrebbe potuto accadere. Bravi che siano e resi indulgenti dall’infermità, questo padre e questa madre a un certo punto avrebbero potuto dire: “Ma figlio benedetto, perché non leggi di giorno?”. E invece questi due erano andati a colpire così lontano da capire che la notte era più propizia al figlio poeta. Avevano capito che la poesia non era il ripiego del figlio malato, che la poesia aveva sopravanzato la malattia stessa che dapprincipio l’aveva nutrita. Non so come Clemente in vita abbia ripagato i suoi genitori; per la verità credo che non abbia pagato affatto, dato che i figli non pagano mai. Nelle sue poesie non li nomina, una volta nomina invece la nonna. Ma i genitori, in genere, non vogliono essere pagati, e neanche questi a quanto pare. “Abbiamo fatto per lui tutto quello che abbiamo potuto”, e almeno di questo erano contenti.
Lesse molto anche nell’ultima notte,quella tra sabato e domenica. La madre si svegliava ogni tanto e vedeva filtrare la luce,finché, non vedendola più, potè dirsi: “Dino ha spento” e addormentarsi profondamente anche lei. Verso le sette, quando si svegliò, udì un rantolo, oppure (non sa bene) quando un rantolo la svegliò, corse di là appena in tempo per vedere Dino spirare sul cuscino senza una parola. Aprì la finestra sul muraglione, schiaffeggiò il figlio, come ora, per farci vedere, schiaffeggia la faccia bagnata del marito, gridò per un medico che a Colledimacine non c’è. Poi,non subito il vero dolore, ma l’ebetudine stuporosa, quella che chiamano ‘la crisi della presenza’, e cioè l’insostenibile constatazione che la persona che poco fa c’era ora non c’è più.
Siamo qui a cercare di ridurre in letteratura la morte di Clemente Di Leo. L’operazione è banale a cospetto di quel grande evento dissolutore, ma pure si deve fare sia per dichiarare la nostra opposizione alla morte a ventiquattro anni sia per rendere, in quel poco che a noi è possibile, una testimonianza a suo favore in forma decente. Clemente lascia ben poco, i suoi legami con la terra erano così tenui, e per ciò il volo gli è riuscito così bene. Non aveva l’orologio,né l’accendino, né un portachiavi. Non aveva neppure l’automobile. Nei registri delle proprietà non ci saranno volture da fare, sistemare la sua successione sarà faccenda di un la sua giacca la metterà il fratello che ha giusto la sua misura; i suoi libri si divideranno in un paio di appartamenti, quando, tra qualche anno, già fornita di tutto il resto si sentirà il bisogno di arredare la casa anche con qualche libro; le trecentomila lire che aveva appena vinto al premio “La Madia” dell’Aquila (non ne aveva mai avute tante insieme, chissà cosa pensava di farci, chissà in che modo le avrebbe trasformate in poesia) andranno per le spese del funerale e del loculo. Non lascia figli che possano ricordarlo con ostinato rimprovero. Il ricordo certamente resterà nei genitori, ma per gli altri, a cominciare dal sottoscritto, quanto ancora potrà durare? E del resto, anche con la migliore buona volontà del mondo, come si fa a ricordare a lungo uno che è vissuto così poco? Per i suoi fratelli e per i coetanei del suo paese sarà un ricordo di gioventù, il ricordo di uno che è scomparso prima che la vita cominciasse davvero. Per i letterati che l’incontrarono a Lanciano, a L’Aquila, a Roma, sarà un episodio che si circoscrive in tre anni scarsi, dall’ottobre del ’67 a giugno del ’70.
Resta la sua tomba, che finalmente ha ridotto alla normalità questo ragazzo ribelle. L’avremmo volentieri immaginata messa in mezzo alla campagna grama del suo paese, non in una località pittoresca, ma all’ombra rada di un fico, i fichi che spesso escono dai suoi versi, o in cima a una di quelle grigie macerie dove crescono rovi robusti come mazze ferrate. Invece sta in un brutto colombario, in un loculo della fila più bassa, ben allineato con gli altri. Sul cemento fresco, in attesa che sia pronta la lapide, un dito ha scritto: Dino; il suo nome nuovo nuovo, portato così poco, servirà ora ai muratori a rintraccia re il suo feretro.
Restano i suoi versi. Vorremmo provare a dirli immortali, ma questa parola, abituati come siamo a vivere, e ad operare noi stessi, nell’ambito di una letteratura che non dura oltre la cronaca del quotidiano, non abbiamo il coraggio di scriverla. Diciamo dunque che i suoi versi gli sopravvivono, anzi gli sopravvivranno, lasciando indeterminati sia la durata della sopravvivenza sia l’inizio di questa sua vita superstite. Abbiamo fiducia nella poesia di Clemente, pensiamo che uscirà e girerà. In questi giorni l’abbiamo nuovamente riletta; vi cercavamo anche una consapevolezza o un annuncio o una premonizione della sua morte (di uno che muore si cerca sempre di appurare se aveva un’idea del grosso fatto che stava per succedergli). In questi giorni d’estate in cui la vita s’inganna con un di più di vistosa letizia, la sua poesia ci si è rivelata più vasta di come al ricordavamo, comprende anche questa gente che va al mare con ombrelloni colorati, e lui forse non aveva fatto in tempo a vederla. La sua poesia è illimitata, si può andarci dentro, sempre più dentro, e non esaurirla, così che con Clemente si può ricominciare ogni volta da capo e questo io, che sono lettore un po’ pigro, sono capace di farlo solo con i poeti che hanno fama di grandi.
Una volta, cinque o sei anni fa, Clemente giovinetto, per farsi pubblicare, pensò questo espediente: mandò al Ponte, l’importante rivista fiorentina, alcune sue poesie, dicendo però che erano di un suo amico, un immaginario Massimo Rocovic, morto giovanissimo. L’espediente funzionò: pubblicare versi di un poeta morto giovanissimo è un buon colpo, la morte di un giovane è già in se stessa un fatto poetico e un po’ di quella poesia circonfonde anche le sue vestigia letterarie. Se le cose stanno così, se morir giovani davvero giova nel mondo delle lettere, vogliamo ora pubblicamente annunciare ai redattori e agli editori d’Italia che Clemente Di Leo è morto per davvero ed aveva solo ventiquattro anni.
da “Ragionamenti e altre poesie”, Carabba, Lanciano, 1982
Un daziere rigoroso di Daniela Di Cecco
Un daziere rigoroso
di Daniela Di Cecco

Un giovinetto con il cuore colmo di passione e la testa carica di determinazione.
E’ questa la fotografia di Clemente Di Leo che traspare dal racconto di Antonio Antrilli, che per il poeta, oltre che amico di scorribande e passioni, è stato anche… insegnante. Non d’arte, ma di un mestiere particolare… Perché Di Leo viveva per il suo amore per la poesia, ma aveva anche bisogno di lavorare. Ne aveva bisogno per mettere da parte qualche soldo che il poeta, imprenditore di se stesso, investiva sui suoi versi.
Antonio Antrilli faceva il daziere a Torricella Peligna. Era incaricato dal Comune di riscuotere le tasse. Ed è proprio questo mestiere che lo ha avvicinato a Clemente che per alcuni anni è stato daziere a Colledimacine. <Me lo ricordo bene Clemente – inizia Antrilli, -, un ragazzo squisito>.
<Non trovava lavoro, povero Clemente. E lui di soldi ne aveva bisogno per potersi pagare le sue spese. Così fu assunto dall’amministrazione civica e ricevetti l’incarico di spiegargli come si faceva il daziere. Due volte alla settimana – rammenta – di buon mattino partivo da Torricella per recarmi a Colledimacine. Mi ero da poco comprato la prima macchina, di cui andavo fiero. Il percorso da compiere era scomodo e tortuoso. La strada non era asfaltata, e soprattutto quando il tempo volgeva al brutto, fatto frequente dalle nostre parti, si faceva una gran fatica a compiere quel tragitto, seppur non lunghissimo>. Ma ne valeva la pena. <Ha imparato subito a far conti e a incamerare balzelli. Non ho mai voluto niente da lui – aggiunge Antrilli – e i miei sacrifici sono stati ampiamente ripagati dalle giornate passate insieme>.
Di Leo portava avanti il suo incarico municipale con certosina pazienza e con attenzione. <Nelle riscossioni aveva fermezza. Non si faceva abbindolare. Era determinato e severo. Riusciva bene in tutto ciò che faceva, perché era un giovane con una spiccata intelligenza e, a dispetto della sua verde età, era maturo e determinato>. Ma non era soltanto il mestiere di daziere ad unire il poeta e Antrilli. <Passavamo ore ed ore a chiacchierare, nella sua piccola stanza o con gli amici al bar>. Dove andavano anche a giocare a carte, a “bestia” e a “tressette”. In realtà quello delle carte per Di Leo era un passatempo trasformato in una sorta di attività secondaria da cui trarre un certo guadagno. Sì, perchè i soldi che vinceva li metteva da parte, per far crescere, di giorno in giorno, il gruzzolo che serviva a finanziare la sua vera e grande passione, la poesia. Così anche i pochi spiccioli racimolati su quel tavolino del bar erano per lui un piccolo risparmio da investire nella poesia. E c’è chi sussurra che Clemente molte volte non vinceva per abilità, piuttosto barava…
<Parlava di continuo delle sue poesie – riprende Antrilli – e mi ha regalato libri suoi, che conservo gelosamente>.
Il racconto di Antonio Antrilli si ferma qui. Il giorno del funerale lo ricorda bene. Ma in questo racconto non trova posto.
L'ultima indimenticabile notte di Daniela Di Cecco
L’ultima indimenticabile notte
di Daniela Di Cecco

Sono passati più di trent’anni dalla sua morte, eppure è con emozione, commozione e un velo di tristezza che Pietro Di Luzio ricorda Clemente Di Leo, col quale ha condiviso le sue due più grandi passioni, la poesia e la politica.
Una testimonianza, quella di Di Luzio, geometra di Torricella Peligna, in cui emerge tutto il suo orgoglio per aver conosciuto un grande uomo e un grande poeta. <Di Leo è il poeta – sottolinea Di Luzio –. E’ unico e indimenticabile>.
E’ un fiume in piena, il suo racconto; parole che scorrono senza sosta, ricordi che si accavallano a ricordi, immagini che ritornano alla mente. In ogni parola pronunciata, in ogni pausa sospirata, si avverte un’emozione: un sussurro di gioia, a volte, un velo di tristezza, altre volte.<Perché la pienezza d’animo che ha contraddistinto Di Leo nella sua breve, eppure così intensa vita – afferma Di Luzio – non può scemare nel tempo>.
Il racconto del geometra Di Luzio parte dalle sue passioni politiche, quelle condivise con il poeta Di Leo. Il Partito socialista, il Psiup (Partito socialista italiano di unità proletaria) in cui Di Leo si era candidato, l’appartenenza all’associazione Nuova Resistenza. <Quando è entrato in politica – racconta Di Luzio – non ne sapeva nulla. Eppure – e qui la sua voce si arricchisce di un colore più intenso, un misto di fierezza e ammirazione – dopo pochissimi giorni ha tenuto il suo primo comizio. Sembrava espertissimo>.
Già, perché Clemente Di Leo per le parole, scritte su un foglio o pronunciate in pubblico, aveva un amore speciale, un amore che trasformava le sue parole in arte. E non perché avesse avuto la possibilità di studiare. <Si era fermato alla quinta elementare – racconta ancora Di Luzio -. Aveva diversi problemi di salute e pertanto non aveva proseguito gli studi. Ma lui era un autodidatta, intelligente e sveglio>.
Non era potuto andare a scuola Clemente Di Leo. Così si era portato la scuola a casa. <La sua stanza – riprende Pietro Di Luzio – era piena di libri, riviste e documenti. Insieme passavamo giornate intere a leggere poesie, a confrontarci sull’uno o sull’altro aspetto della vita . Parlavamo di tutto, ma tutto riconduceva inevitabilmente alla poesia, ai versi, e al suo amore per la letteratura>.
Le parole di Di Luzio arrivano a chi le ascolta come immagini di quegli attimi. Ecco prendere, quindi, forma il disegno della vita di Clemente Di Leo, questo bel giovane dagli occhi intensi, occhi che si illuminavano ad ogni pagina scorsa. E tutto quello che apprendeva, Clemente Di Leo lo trasformava in emozioni e sensazioni che prendevano forma nelle poesie.
Ma dal racconto di Pietro Di Luzio emerge anche che Di Leo non era un poeta scanzonato, che viveva esclusivamente nella leggerezza della sua arte. Era un tipo in gamba, come si direbbe ai giorni nostri. Sapeva darsi da fare anche nelle cose concrete della vita, non si risparmiava i sacrifici. Era uno che si accorciava le maniche senza lamentarsi, con la determinazione e la costanza di chi non si scoraggia mai e va avanti per la propria strada. Era poeta, ma era anche editore e venditore di se stesso. Le sue poesie erano le sue creature, dal momento del parto al momento in cui diventavano patrimonio di chi aveva voglia di ascoltarlo. <Si stampava i libri da solo – ricorda il geometra Di Luzio – e li vendeva porta a porta. Ai giorni nostri si potrebbe dire che era anche l’agente di se stesso. Utilizzava i piccoli ricavi delle vendite dei libri precedenti anche per fare i suoi viaggi>. Viaggi letterari, perché qualunque cosa facesse, Clemente Di Leo la faceva in funzione del suo amore per la poesia. E non mancava qualche piccola bugia. Una di queste bugie l’amico Pietro Di Luzio la ricorda perfettamente e la racconta anche con un po’ di orgoglio: <Aveva preso in giro molte case editrici, tra cui la Mondadori, e in particolare il periodico Panorama. Clemente aveva infatti scritto anche splendidi versi in latino, ma li aveva spacciati per creazioni di un misterioso autore straniero. Lo faceva – racconta ancora Di Luzio – per attirare l’attenzione delle case editrici perché, diciamoci la verità, era estremamente sottovalutato>. Anche nella sua piccola comunità, quella di Colledimacine e dei piccoli centri limitrofi, non era molto conosciuto, né apprezzato. <Aveva mandato articoli che erano stati pubblicati in tutta Italia – ricorda Di Luzio, e questa volta la sua voce si tinge dei toni dell’amarezza – ma qui nessuno aveva compreso quale grande poeta fosse e sarebbe diventato davvero se…>.
<Me lo ricordo bene il giorno del suo funerale – continua – e mi ricordo perfettamente anche la sera precedente alla sua morte. Insieme a Clemente e ad altri amici avevamo festeggiato il premio “La madia d’oro” che aveva ritirato a L’Aquila. Quella sera non volle sentire ragioni. Niente divieti (imposti a causa del suoi problemi di salute, ndr). Clemente per una volta volle “esagerare” con cibo e alcool e concedersi tutto ciò che gli era da sempre proibito. Mangiò e bevve tanto… E’ stata una notte indimenticabile. Di incredibile felicità. Di appagamento, gratificazione e compiacimento>.
<Poi abbiamo sentito… la morte>. Quella morte che ha cancellato sì l’esistenza di un ragazzo pieno di ambizioni. Quella morte, però, che non potrà mai cancellare le sue emozioni, quelle che è riuscito così bene a imprimere nelle sue liriche.
E si precipitava a casa a scrivere…di Conny Melchiorre
E si precipitava a casa a scrivere…
di Conny Melchiorre

Pur abitando in un paese così piccolo, un po’ isolato tra le montagne e, nonostante avesse dovuto interrompere prematuramente gli studi, Clemente Di Leo non era culturalmente isolato, anzi, potrei dire che con il suo entusiasmo, con i suoi viaggi e la sua indagine letteraria da autodidatta incarnasse una vera e propria mentalità europea>.
Così esordisce Albino Cavaliere, professore di italiano ed ex sindaco di Gessopalena, ricordando l’amico Clemente, compagno nel 1970 nelle elezioni provinciali.
<Di Leo ha creato nelle sue poesie un modo proprio di esprimersi, con uno stile che lo avvicina a Cesare Pavese. Inizialmente ha aderito al “Gruppo ‘63” un movimento letterario di avanguardia facente capo al Sanguinetti, distaccandosene successivamente – ricorda Cavaliere – influenzato dall’ermetismo, lo impreziosisce affrontando una serie di problematiche esistenziali con degli interrogativi di tutto il genere umano. Lui da solo tra le pietre, come recita in una sua poesia. (Mi sono ritrovato con un nome tra pietre, e senza risposte mi consumo con loro). Tutto il mondo circostante gli appare come una roccia con la sua durezza economica e sociale. (Questa è la contea dei ginepri ma devi spaccare la scorza delle querce con un pugno tanto è la forza per poterci vivere)>.
Clemente Di Leo era interessato alle problematiche sociali della sua gente e cercava di trovare delle soluzioni anche tramite un impegno politico.
Negli anni Cinquanta sembrò che Colledimacine avesse trovato la soluzione per la sua risalita economica. Una scialuppa di salvataggio che avrebbe risollevato le sorti dei suoi abitanti. Fu aperto un caseificio e le varie famiglie acquistarono delle mucche. Il latte sarebbe stato venduto all’azienda. Anche la famiglia Di Leo seguì questa scia. Gli affari per un po’ andarono bene per tutti, ma poi il caseificio fallì e nella metà degli anni sessanta il sogno s’infranse. Lo stesso padre del poeta fu costretto ad emigrare all’estero.
Di Leo divenne daziere, andò ad apprendere il mestiere a Torricella Peligna.
Fu qui che si conobbero, lui e Cavaliere, grazie ad un amico in comune, Pietro Di Luzio.
Entrambi militavano all’interno del Psiup, Partito socialista italiano di unità proletaria, nato nel 1964 da una scissione del Psi e sparito nel 1972.
Cavaliere e Di Leo si candidarono alla Provincia. <Le votazioni – ricorda Cavaliere – si svolsero in giugno, gli suggerii io stesso di presentarsi come indipendente di sinistra, visto che non aveva la tessera del Psiup, però lo avvertii che sarebbe stato difficile essere eletto. Dopo i risultati, negativi, non fummo in contatto per alcune settimane e all’improvviso, in luglio, mi giunse la notizia della sua morte. Fu uno schock per tutti. Sapevo del suo problema al cuore. Mi sentii in colpa perché pensavo che fosse rimasto talmente deluso per le elezioni che si fosse sentito male per questo. Poi, invece, seppi di come erano andate le cose e del premio “La madia d’oro” vinto all’Aquila>.
A riguardo Cavaliere rammenta i racconti di quegli amici di Lama dei Peligni e di Taranta Peligna che andarono con lui nel capoluogo regionale a ritirare il premio.
<I sostenitori di quel giorno ricordano dell’euforia di Clemente che dopo la cerimonia salì sul muretto della Fontana delle 99 cannelle e iniziò a declamare le sue poesie. Lui era solito ad impeti di questo genere. Se si trovava a passeggiare per Colledimacine e gli venivano in mente dei versi, lasciava tutti dicendo che doveva andare a scrivere e si precipitava a casa>
<Clemente Di Leo – conclude Albino Cavaliere – aveva un grande cruccio, quello di sapere che sarebbe morto giovane e che il successo insieme al valore delle sue opere sarebbe giunto solo dopo la fine. Era cosciente della sua illimitata qualità poetica e avrebbe voluto un riconoscimento in vita. Riuscì a far pubblicare alcune delle sue poesie sulla rivista “Il ponte” edita a Firenze e fondata da Piero Calamandrelli. E alla fine riuscì ad assaporare in vita l’elogio della sua bravura poetica: proprio con quel premio vinto a L’Aquila una decina di giorni prima del compiersi del suo triste destino>.
Sulle vie bianche della neve di Conny Melchiorre
Sulle vie bianche della neve
di Conny Melchiorre
<A Dino e alla sua reggia azzurra>.
Così recita la dedica che Bartolo Iossa, docente di filosofia residente a Chieti, ha apposto alla sua ultima opera, “Le betulle di Friedrich”.
Dino è il poeta Clemente di Leo e la reggia azzurra è Colledimacine, il suo natio “borgo selvaggio”.
A distanza di oltre quarant’anni l’amico Iossa ricorda con immagini colorite quell’incontro e quelle passeggiate notturne sulle vie imbiancate dalla neve a discutere di poesia, politica, religione, sogni…
<Era l’ottobre del ’62 ed ero arrivato da poco. Durante quell’anno scolastico e per quello a seguire sarei stato maestro alle scuole elementari di Colledimacine. Avevo 21 anni. In paese – racconta – c’era un unico bar, in possesso di un bene prezioso: un televisore, finestra sul mondo. Ero seduto ad un tavolino quando mi accorsi di un ragazzo che mi osservava. Stavano trasmettendo il telegiornale che parlava della crisi di Cuba. La cronaca nazionale era molto interessata a quella vicenda.
E non solo la cronaca nazionale… “Che cosa ne pensi?” Alzai lo sguardo e ritrovai quel ragazzo in piedi vicino a me. Ne sfociò un vivace dibattito, cui ne sarebbero seguiti mille ancora. Sul tavolo avevo poggiata l’edizione Mondadori delle poesie di Salvatore Quasimodo. “Che ne pensi?”, incalzò nuovamente Dino. Era un indagatore. Fummo amici fin da subito>.
<Quell’invernata – aggiunge – fu particolarmente fredda. Tra ragazzi ingannavamo il tempo passeggiando. Sul più bello Dino scompariva. “Ma cosa gli sarà successo?” mi chiedevo. Lo scoprii poco dopo. Folgorato da un’idea correva ad appuntarsi i pensieri di quel momento in poesia, su dei foglietti. Quei famosi pezzetti di carta che arrotolava e gelosamente custodiva.
“Quando la poesia chiama, io devo andare”. Con questa espressione motivava il suo comportamento bizzarro. Dino aveva un’idea particolare della poesia: “Essa è una vera e propria forza creatrice che deve essere disciplinata nelle parole e che poi deve caricare i termini di un aspetto segreto che comunemente sfugge”. Dino sosteneva che la poesia è ovunque, “mica solo nella luna, nelle stelle, nell’amore”. Il vero poeta è colui che la sa trovare anche dove nessuno la vede. Alberto Moravia dà una definizione simile a questa, chiamando il poeta “rabdomante”, “colui che sa trovare l’acqua dove nessuno la trova”. Dino si sentiva quasi afferrato dalla poesia>.
Eppure Clemente Di Leo non era solo un poeta era anche un narratore: <Egli – ricorda Iossa – possedeva un’altra peculiarità, quella di conoscere molto bene alcuni personaggi del suo paese. Quando si abita in un piccolo centro è molto facile scoprire vizi e virtù dei propri concittadini, caratteristiche che spesso si trasformano in soprannomi. Anche lui ne aveva uno: “Il primo lupo rosso della Maiella”, attribuito probabilmente per la sua fisicità. Clemente trasformava alcuni di loro nei protagonisti dei suoi racconti, molti dei quali pubblicati sulla rivista “Capolavori notturni” che risultava essere pubblicata a Siena e sulla quale si firmava Dino Delli Pizzi, prendendo a prestito il cognome materno. Ed ecco vivere sulla carta uomini esistenti, come Lucane, detto “carta bianca” perché era “solito fare il comodo suo” o Micesco o Maramaida>. In realtà quel foglio letterario era una creazione di Di Leo, che ne era l’editore.
Ricordate la storia di Massimo Rocovic, morto suicida, stratagemma usato dal Di Leo per interessare una rivista alla pubblicazione delle sue poesie? Sui fogli dei “Capolavori notturni” un’altra scoperta… una foto e sotto un nome: Massimo Rocovic. Quel “furbone” di Dino per rendere più veritiera la sua storia e testimoniare la reale esistenza del fantomatico artista gli aveva dato un volto. Ed indovinate chi ritrae la foto?! Già è lui, che si era voluto dare un tocco di mistero indossando un trench. Indovinate di chi era il trench? Di Bartolo Iossa.
<Di Leo in quegli anni – seguita – aveva avuto la possibilità di leggere molto non solo perché prendeva i libri in prestito dalle biblioteche di Chieti e di Pescara ma anche perché a Colledimacine erano arrivati i volumi destinati alla struttura denominata “Centro di lettura”. Egli divorò tutta la grande letteratura europea da lì. Nel ‘64 andai a insegnare a Chieti. Dino mi veniva a trovare spesso e mi portava in dono i suoi testi. Un giorno risposi alla telefonata che mi annunciava la sua morte. Lui stesso mi aveva accennato sulla sua malattia. Non compresi che fosse tanto grave>.
E il rapporto di Dino con Colledimacine?
<Era un legame molto particolare. Al contempo voleva stare nel paese natio e voleva andare fuori. Da una parte – riprende Iossa – lo avvertiva come una gabbia, dall’altra era il luogo di maggiore ispirazione poetica. Erano le pietre che lo attraevano in modo particolare. Egli considerava la loro ruvidità come “l’altra faccia della poesia”. Quest’ultima, secondo la sua concezione, è l’aspetto segreto della verità. La verità, per lui, ha un’essenza ruvida e la bellezza della poesia rimanda alla ruvidezza, in un rapporto reciproco indissolubile. A Colledimacine egli era visto come un ragazzo buono, bravo, benvoluto da tutti e da proteggere, ma anche come un personaggio strano che era come “invasato dalla poesia”>.
<Il giorno del funerale tornai in paese, c’era tantissima gente e si respirava un clima di grande commozione – conclude – . Mi guardai intorno e pensai “Se Dino fosse qui scoppierebbe a ridere per tutta questa serietà”, a causa della sua trasversalità rispetto ai valori un po’ consacrati. Era aperto, gioviale e gli piaceva stare in compagnia>.
Perché dedicare un libro di filosofia ad un poeta?
<Il mio testo è filosofico eppure non tratta solo di filosofia. Caspar David Friedrich è un pittore del primo Ottocento. La mia indagine sulla sua opera si snoda attraverso più crinali, tra filosofia e letteratura, tra letteratura e poesia, tra poesia e pittura. Con Dino ragionavamo spesso su questi argomenti. “Il poeta – dicevamo – è in grado di avvertire certi mutamenti profondi del reale prima dei filosofi”. Il filosofo lavora sulle intuizioni primigenie dei poeti. Per questo ho dedicato il testo al mio amico Dino, il poeta>.



